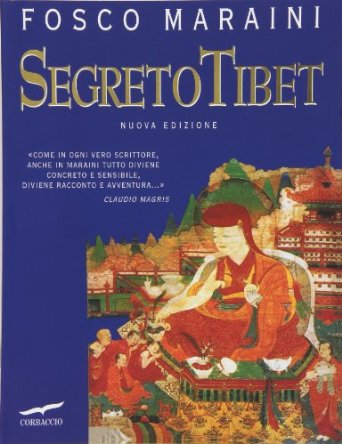 Le origini storiche del genocidio ed etnocidio della Cina contro il Tibet
Le origini storiche del genocidio ed etnocidio della Cina contro il Tibet
“Segreto Tibet”, di Fosco Maraini, Corbaccio Editore. Ogni commento su questo libro, di grandissima fama e di enorme importanza, sarebbe superfluo. Le sue pagine sono un eccezionale documento artistico, culturale ed antropologico del Tibet dei tempi ‘felici’, quando la ‘modernità’ era ancora lontanissima da quelle montagne, e gli orrori del nazimaoismo ancora di là da venire. Oltre ai primi quattordici capitoli, dedicati appunto tutti al suo viaggio, di particolar pregio sono il XV° (Note sul Buddismo tibetano) ed ancor più il XVI° (Note sulla storia del Tibet), forse la miglior sintesi che abbia mai letto su un argomento tanto lontano e complesso. Da quest’ultimo capitolo, appunto, ho voluto proporre la lettura di alcune pagine, interessantissime ed illuminanti non solo perché testimoniano la barbarie dell’occupazione cinese in Tibet, ma soprattutto perché analizzano con grandissima competenza storico-antropologica la mentalità dell’occupante, e ci aiutano a capire nell’intimo la posizione politica e culturale della Cina, sia di quella di allora ma anche di quella odierna, nei confronti della questione tibetana. Leggete, inorridite, ‘compatite’ buddhisticamente, e fate tutto ciò che potete per la libertà del Tibet e del suo popolo. Come ha scritto tempo fa Majid Valcarenghi su “Re Nudo”, “a Pechino scientificamente è stato messo a profitto quello che il Nazismo aveva solo immaginato”. LHA GYAL LO! (Che gli Dèi siano vittoriosi!)
II°- L’indipendenza (1912-1951)
(…) Un personaggio come Mao Tse Tung diviene più facilmente comprensibile se lo si assimila ad una figura archetipica della storia cinese (…) cioè al Fondatore di Dinastia, (…) figura dal carisma irresistibile. Le dinastie, ricordiamolo, sono organismi durevolissimi, contando mediamente su due, tre secoli di vita. Inoltre in Cina non v’è alcuna chiesa od organizzazione ideologica capace di contrastare o di soppiantare al momento opportuno il Partito Comunista. L’identificazione tra Cina ideologica, Cina nazionalista, Cina imperialista, e dinastia, è totale. (…) Tale individuo eccezionale si leva sui contemporanei come una montagna, si trova al di là e al di sopra di ogni giudizio comune, e gode di un carisma più divino che umano, poiché dimostra, nella sua persona e col suo successo, d’aver ottenuto l’indefinibile benedizione del Mandato Celeste. Che in questo particolare caso si trattasse di un comunista, presumibilmente ateo, non ha importanza; gli archetipi non poggiano su basi razionali, funzionano nel profondo irrazionale, emotivo e segreto degli uomini, e si nutrono di occulte linfe del passato vicino e lontano. Che la dinastia appena iniziata si trasmettesse il potere per cooptazioni, elezioni o altro, invece che per seme ereditario, è circostanza contingente. Ciò che importava era che la nuova dinastia comportasse rigenerazione sociale profonda, da un lato, e riaffermazione della grandezza cinese dall’altro. Il Kuomintang aveva perso il mandato celeste perché lo si giudicava corrotto, debole, rinunciatario, troppo legato agli stranieri. I comunisti promettevano palingenesi sociale e grandeur per la patria. A loro andò il Mandato.
(…) La Cina considera suoi quei territori sui quali, in qualche momento della millenaria storia, ha esercitato una qualsiasi forma di sovranità. Era ovvio dunque che la nuova dinastia pensasse al più presto di riportare le bandiere, questa volta senza draghi ma con stelle, falce e martello, sui confini di tutte le regioni periferiche, compresi il Sinkiang e il Tibet, anche se abitate da genti diversissime dagli Han. Le contraddizioni profonde, stridenti, tra idea imperiale e idea comunista non si presentavano neppure alla soglia di quelle menti. La nuova dinastia era solo incidentalmente comunista, prima di tutto era cinese.
Il Tibet nelle mani della Cina (dal 1951 ad oggi)
Fin dal gennaio 1950, (…) il nuovo governo cinese rese pubblica la sua decisione di “liberare” il Tibet. “Liberare” il Paese delle Nevi? Ma se per la prima volta da due secoli esso era veramente, sostanzialmente, libero! Liberarlo dalla libertà, dunque? Se ci si riflette un istante era proprio questo il fine del programma d’azione. A parte le ataviche considerazioni di prestigio del Centro-Fiore[1], un Tibet libero sui fianchi, eventualmente aperto ad alleanze poco gradite, era da evitarsi in modo rigoroso: dunque occorreva liberarlo proprio dalla libertà. Per fare questo i cinesi completavano quell’ironico “liberare” con la frase “dalle influenze imperialistiche”. Ma da quali? L’Inghilterra si stava ritirando nell’arcipelago d’origine, e l’India aveva ben altri problemi a cui pensare. Si trattava insomma della più ipocrita montatura immaginabile.
(…) Dopo il 1953/54 il cielo cominciò ad abbuiarsi. Le prime scintille di un grosso fuoco a venire si notarono nelle zone orientali del paese, nel Kham, sia perché fu là che i cinesi dettero inizio alle più radicali riforme, sia perché i montanari di quelle province erano, per antichissima tradizione, i più insofferenti d’ogni giogo. In quegli anni la guerriglia tra i Kham-pa, gli Ngolok ed i cinesi prese aspetti di ferocia inaudita, con colpi di mano, vendette, distruzioni, torture, bestialità d’ogni genere da ambo le parti. (…) Il conflitto era, a tutti gli effetti, una guerra di religione, combattuta coll’accanimento di cattolici contro anabattisti o di mussulmani contro kafiri. Se da una parte stava una religione convenzionale, il buddhismo, dall’altra ne stava una che si proclamava non-religione, ma con religioso furore. Essere anche moderatamente ricco equivaleva a peccare non contro gli Dei, ma contro il dio-popolo; quindi il colpevole andava denudato d’ogni avere, e se resisteva un tantino, distrutto. I lama peccavano in quanto consumavano senza produrre, dunque per loro valevano i medesimi principi. I templi, i monasteri andavano sconsacrati, sguerniti d’ogni inutile cianfrusaglia, adibiti a stalle, caserme, granai, officine. I bambini andavano tolti ai genitori, se questi mostravano il minimo segno d’eresia; venivano allora inviati in Cina per essere rieducati in un’atmosfera “più sana”.
(…) Le famose riforme, che avrebbero dovuto realizzarsi gradualmente tenendo conto delle particolari condizioni sociali e religiose del mondo tibetano, secondo lo spirito dell’Accordo dei 17 articoli, vennero invece adesso attuate di colpo e nel modo più radicale, fin dal giugno del ’59. Si riesaminarono ovunque i diritti di proprietà fondiaria, immobiliare, del bestiame, con pura e semplice confisca per coloro che in qualche modo erano stati collegati con la ribellione, con varie forme di compenso (più teorico che reale) per gli altri. La società tibetana fu completamente sconvolta, profughi a decine di migliaia cominciarono a varcare i colli dell’Imàlaia cercando rifugio in India, nel Bhutan, nel Nepal, spesso in condizioni disastrose. Non solo i ricchi erano presi di mira, lo erano anche i piccolissimi proprietari: e lo erano, con maggior durezza, si capisce, i monasteri. (…) [Per queste tragedie, la Cina] si giustificava cogli argomenti ben noti dei colonialisti d’un tempo, quelli che sentivo da ragazzo quando l’Italia era impegnata in Libia, in Eritrea, in Etiopia, in Somalia: “Ma vedi, noi portiamo la pace, la sicurezza, il benessere, costruiamo strade, ferrovie, campi d’aviazione, insegniamo ad usare la luce e il telefono, costruiamo ospedali, scuole, fabbriche, mettiamo gli indigeni al corrente di un’agricoltura moderna, scientifica, meccanizzata”.
(…) Ci si trova di fronte al fatto fondamentale: che la libertà di un popolo è un bene al di là e al di sopra di ogni prezzo, d’ogni baratto. Un bene che nessuno ha il diritto di alienare. E’ uno dei grandi paradossi della nostra epoca che il mondo “capitalista, reazionario, imperialista” abbia ormai riconosciuto in pieno questo principio da quasi mezzo secolo, agendo di conseguenza. Tutti i suoi imperi coloniali d’un tempo sono stati smantellati, smembrati, dissolti. Restano in piedi solo quelli del mondo cinese “socialista e progressista”, il quale, con i suoi bei discorsi, le sue belle colombe della pace, agisce in pratica ancora come le vituperate potenze coloniali del secolo scorso.
Bisogna inoltre tener presente che il giogo coloniale cinese è particolarmente pesante, per antichissime, millenarie tradizioni. (…) Il nucleo Han di duemila anni or sono è andato via via espandendosi nei secoli sinizzando costantemente nuovi gruppi etnici. Dopo due, tre, dieci generazioni i barbari d’un tempo si erano finalmente trasformati in gente come si deve, civile, piano piano assimilati agli altri cinesi Han. Il tempo di queste operazioni conta poco. I cinesi sanno essere immensamente stabili. Il tempo si misura a ere geologiche. La Cina si costruisce a stratificazioni oceaniche.
L’opera di sinizzazione è naturalmente fondata sul concetto di una superiorità intrinseca, assoluta, della civiltà cinese su ogni altro consimile frutto dell’evoluzione umana. (…) Al centro stava la Cina (“Il Centro-Fiore”), depositaria d’ogni valore civile, attorno si disponevano i barbari. (…) I cinesi come colonialisti mirano tutti per istinto profondo, per tradizione etnica, a sinizzare: quindi esercitano una pressione sottile, continua, involontaria, perché i “barbari” abbandonino i loro modi grezzi e zotici di mangiare, vestire, per adeguarsi ad abitudini e costumi più metropolitani e di maggior rispetto. Occorrono cento, duecento anni? Che importa? Cosa sono dieci, quindici generazioni nella nostra millenaria storia!
(…) Si presentò all’orizzonte un’altra terribile tempesta: quella della Rivoluzione Culturale. E’ vero che essa fu mostruosa anche in Cina, ma in Tibet ebbe risvolti forse ancor peggiori, sia per l’isolamento del paese, sia per quel fondo di sciovinismo culturale sinico, che trovò libere le redini sul collo e poté scatenarsi a suo piacimento. La Rivoluzione Culturale si fondava sull’idea maoista della “rivoluzione perenne”, sulla necessità d’una distruzione del vecchio per una futura ricostruzione del nuovo. Ficca certe idee elementari nelle teste di ragazzotti già nerboruti di muscoli, ma parecchio crudi di pensiero e informi di sentimenti, e vedrai che anche gli Uffizi, il Prado e il Louvre possono trovarsi in pericolo.
Le famigerate Guardie Rosse iniziarono le loro attività a Lhasa nell’agosto del 1966. Già un mese prima alcuni fanatici erano arrivati dalla pianura portando il nuovo verbo di Mao. In poco tempo si costituirono due grosse bande nella città. (…) In gran parte si trattava di giovani cinesi che lavoravano nelle nuove fabbriche costruite a Lhasa e nelle vicinanze, ma si dice che anche parecchi ragazzi tibetani s’aggregassero alle masnade. Quasi tutti erano giovanissimi, però alcuni almeno dei capi erano più anziani. Lhasa venne messa sottosopra: La si tappezzò tutta di bandiere rosse, di striscioni con citazioni di Mao; poi si rinominarono strade, piazze, incroci, sostituendo ai termini antichi, che avevano connotazioni religiose, altri più “rivoluzionari” (toponomastica come appropriazione!). L’abitudine tibetana di scambiare sciarpe bianche venne giudicata “reazionaria”; no, ci volevano sciarpe rosse. E fin qui poco di male, erano manifestazioni di esuberanza giovanile abbastanza innocenti. Poi cominciarono i processi, le parate dei condannati alle umiliazioni lungo le strade, le perquisizioni delle case con ricerca di oggetti religiosi “proibiti”, con seguito di violenze contro chi li possedeva.
Una volta lanciate, queste bande di giovani si sentirono padrone del Tibet; tenendo il libretto rosso delle massime di Mao in una mano, salivano sugli autocarri e si dirigevano verso i monasteri, dove poi si scatenavano in orge di distruzione. Se i pochi monaci rimasti non fuggivano, o peggio tentavano di opporsi agli insensati vandalismi, rischiavano di lasciarci malamente la pelle. In quanto alle immagini sacre, venivano fracassate, pestate, sfasciate, bruciate con la voluttà dell’invasamento fanatico. Esiste una fotografia presa di nascosto di una cappella del Norbhu Linka dopo una di queste spedizioni: la stanza sembra una “macelleria di Buddha”, vedi lì ammucchiate braccia, teste, aureole, mani, busti. Insomma, non è più distruzione pura e semplice, è patologia. (…) Ci si domanda come degli esseri umani possano essere caduti così in basso. (…) Nove decimi delle testimonianze della civiltà tibetana sono ormai cenere e polvere. (…)
Gli anni Ottanta e Novanta di fine secolo
(…) Un formidabile testimone del periodo che va dal ’59 al ’92 deve riconoscersi nel monaco Palden Gyatso (di confessione Gelugpa), la cui autobiografia (Tibet, il fuoco sotto la neve, Sperling & Kupfer, 1977) comprende il racconto d’un trentennio circa di detenzione nelle varie prigioni che costellano il Tibet, disegnandovi un paesaggio da vero Gulag, degno dei peggiori tempi sovietici. (…) Attraverso il suo scritto, sempre sobrio, un testo in cui l’eroismo dell’autore e di molti suoi compagni non viene mai enfatizzato o retorizzato, anzi compare quasi di soppiatto, in sordina, venendo scoperto talvolta casualmente dal lettore, traspare chiarissima la perfidia dei cinesi, i quali, ad un livello elementare, brutalizzano i tibetani perché fedeli al Dalai Lama, o per altre ragioni consimili, ma poi, ad un livello più sofisticato e sottile, cercano di dividerli in numerosissime categorie, in modo da poterle, con manovre machiavelliche, manipolare l’una contro l’altra a proprio vantaggio.
Una classifica basilare separò, fin dal 1959, i tibetani in gente “dalle radici buone” e gente “dalle radici cattive”. Alle prime appartenevano i nullatenenti, i fittavoli, i pastori e semplici custodi di bestiame, i manovali e simili, ma bastava il minimo possesso di terra, di bestie, bastava essere titolare di una pur misera bottega artigiana, come bastava qualsiasi legame con le classi abbienti, o peggio con l’aristocrazia d’un tempo, perché la notazione di “radici cattive”, una volta notata sui documenti ufficiali, seguisse il malcapitato sempre ed ovunque. In altre parole, prese forma una sorta di razzismo sociale, con la creazione di caste favorite dal potere o, viceversa, di altre dal potere aborrite.
(…) Palden Gyatso ed altri suoi compagni, definiti come “colpevoli grossi” [vennero torturati] facendo ampio uso del nefando manganello elettrico, una delle più diaboliche invenzioni cinesi: un bastone da infilarsi in bocca, in gola, nello stomaco, nell’ano del martire (e nelle vagine delle monache) causando dolorosissime bruciature. (…) Ai condannati a morte per varie forme di resistenza ai cinesi (…) venivano tagliate le corde vocali, perché all’ultimo istante non gridassero frasi inneggianti ad un qualsiasi valore ideale.
(…) Non per scusare i cinesi, ma per cercare di capirli nella loro bestialità, occorre tener conto che, per millenaria tradizione culturale, essi si sentono investiti del sacro compito di civilizzare il barbaro, di renderlo presentabile, simile agli Han, di liberarlo dalle sue superstizioni e dalla sue rozzezze. In simile quadro ogni mezzo è lecito, stante “l’altezza”, e per loro addirittura “la nobiltà”, del fine. Nei tibetani i cinesi trovano il barbaro più ostico, più difficile a piegarsi, più fortemente asserragliato in sue concezioni originali del mondo, della società, della vita: quindi maggiore e più terribile è la furia della repressione. (…)
Le azioni di forza guidate dalle religioni sono sempre state le più odiose della storia. I russi d’un tempo, come i cinesi d’oggi, si dichiarano atei: ma anche l’ateismo può rivelarsi propulsore di perfidie, motore di crudeltà imperdonabili.
(…) Intanto il potentissimo rullo compressore della sinizzazione forzata continua imperterrito il suo corso, schiacciando senza pietà ogni traccia d’una civiltà millenaria. Si calcola ormai che Lhasa abbia più residenti cinesi che tibetani. Naturalmente la lingua parlata, anche dai tibetani, se hanno la minima ambizione di farsi avanti, è ormai il cinese; il tibetano è disceso al malinconico rango di lingua provinciale, di dialetto. E compaiono sempre più frequenti le scritte verticali, vergate in ideogrammi, a sostituire le eleganti frasi tracciate in sillabe della lingua di Milarepa o di Thonmi Sambhota, antica di un millennio e mezzo. A scuola i programmi prevedono qualche ora di tibetano, ma esse vengono impartite da maestri e da professori cinesi, la cui pronuncia lascia ovviamente molto a desiderare.
Una delle armi più spregevoli, tra quelle impiegate dai cinesi nel loro piano di genocidio culturale dei tibetani, consiste nell’apertura di sezioni a luci rosse nei quartieri nuovi della città. Ma sì, baldi giovani tibetani, sguazzate tra vini e prostitute, drogatevi liberamente, così ci libererete più presto della vostra insopportabile presenza!
(…) Con quali occhi guardare oggi al futuro del Tibet?
Esiste qualche speranza per il “Paese delle Nevi”, per la patria di Milarepa e di tanti altri eremiti poeti che hanno lasciato tracce da segnarsi nella letteratura mondiale, tra i grandi visionari, i grandi illuminati?
(…) Se leggiamo il testo di un importante documento (Schema per lo sviluppo economico e sociale della Regione Autonoma del Tibet, riguardante il piano quinquennale 1996/2000, e nella prospettiva a lungo termine, mirante all’anno 2010, (…) 7 giugno 1996), ci sentiamo raggelare il sangue nelle vene.
Il piano mira freddamente all’integrazione totale dell’economia e della vita sociale e culturale tibetane nell’alveo dell’economia e della società cinesi. Con lucido darwinismo antropico, si prevede che i tanti proprietari agricoli del paese se la vedranno tra di loro, con una serie finale di accorpamenti fondiari redditizi. Nel processo resteranno schiacciati, eliminati, moltissimi contadini che non saranno riusciti ad ingrandire le proprie terre sino alla soglia minima della funzionalità economica. (…) Il documento considera tale circostanza del tutto favorevole. I contadini in soprannumero migreranno verso le città, nel frattempo ingrandite e razionalizzate, e forniranno mano d’opera preziosa a basso costo per le industrie medie e piccole nascenti o in via di sviluppo.
Per i nomadi è previsto qualcosa di simile, mirando a trasformarli in allevatori e produttori di carni, a ritmo molto più serrato dell’attuale. In Tibet, secondo questo ed altri documenti, vi dovrebbero essere circa 23 milioni di capi di bestiame. Insomma, il Tibet dovrà diventare uno dei più grandi centri di produzione di carni macellate, fornitore in tal senso dell’intero territorio cinese.
Fino ad ora i nomadi tibetani (…) sono vissuti in una sorta di idilliaca armonia con le loro mandrie, cedendo al mercato soltanto le bestie pienamente adulte, rispettando almeno idealmente e nelle forme religiose quell’unità tra uomo e animale sottolineata dall’espressione “esseri senzienti” (sem-chen) che comprende tutti e due. Ma se gli estensori del piano predetto fanno sul serio – e trattandosi di un rapporto coloniale sui tibetani non v’è ragione di attendersi ripensamenti o concessioni speciali – i nomadi tibetani dovranno trasformarsi in allevatori di bestie da abbattere appena raggiunti certi pesi stabiliti per legge, senza riguardo all’età. Rapporti personali tra nomadi ed animali? Ma via, dove siamo! I sognatori dovranno adeguarsi alle necessità del XXI° secolo. O lasciarsi schiacciare.
Concludendo: la questione tibetana
(…) I cinesi, si direbbe, sono semplicemente rimasti indietro nell’evoluzione della civiltà. Se i precedenti storici avessero valore probatorio per giustificare l’occupazione di territori altrui, il mondo cadrebbe in una rivoluzione terribile e perenne.
(…) L’occupazione del Tibet da parte della Cina fa parte di un quadro superato della storia mondiale, quello delle conquiste imperialiste e dei domini coloniali, perciò può mantenersi soltanto con la cruda forza, priva di ogni legittimità. E il comportamento bestiale dei cinesi nei riguardi dei tibetani fa talvolta supporre che essi avvertano oscuramente il male sostanziale dell’occupazione nel profondo delle loro coscienze.
(…) In teoria dunque i tibetani hanno i più sacrosanti diritti ad aspirare ad una piena indipendenza. Anche se, in questo fiale scorcio di secolo, si affaccia alla mente dell’osservatore un dubbio orrendo. Certo, il Tibet possiede una cultura, una civiltà profondamente diversa da quelle della Cina. Ma purtroppo, per quanto tempo ancora sarà vero tutto ciò? L’opera brutale, sottile, onnivora, continua, di sinizzazione si protrae ormai da quarant’anni, ed è perciò molto avanzata. Inoltre, un brutto giorno, non c’è scampo, anche il Dalai Lama dovrà morire. La sua successione probabilmente porrà in luce due candidati alla XV reincarnazione: uno grato alla diaspora tibetana, ed uno prescelto dalle autorità di Pechino. E’ ovvio che a contare davvero sugli altipiani sarà la pedina cinese. Allora i nuovi padroni avranno in mano non solo i corpi dei tibetani, ma ne potranno manipolare anche le anime. Non vorrei terminare queste pagine, iniziate nel 1950 con tanto giovanile entusiasmo, su di un tono così lugubre. Cosa possono fare, oggi, i sinceri amici del Tibet? Battersi per una meta limitata ma possibile: quella che consisterebbe nell’ottenere che l’autonomia del Tibet si realizzi nel modo più completo possibile. Far sentire ai cinesi che esiste un’opinione politica mondiale, una pressione in favore del rispetto di quegli accordi in 17 punti proposti e firmati nel 1951. Le Tibet libre, come Le Quebec libre di De Gaulle, è forse slogan di utopisti: ma le Tibet autonome no. Con questo fine in cuore, facciamo sentire per quanto è possibile la nostra voce!>>.
Fosco Maraini
[1] Uno dei tanti nomi della Cina. (…) Centro-Fiore o Fior-Centro (sottinteso “del mondo”).